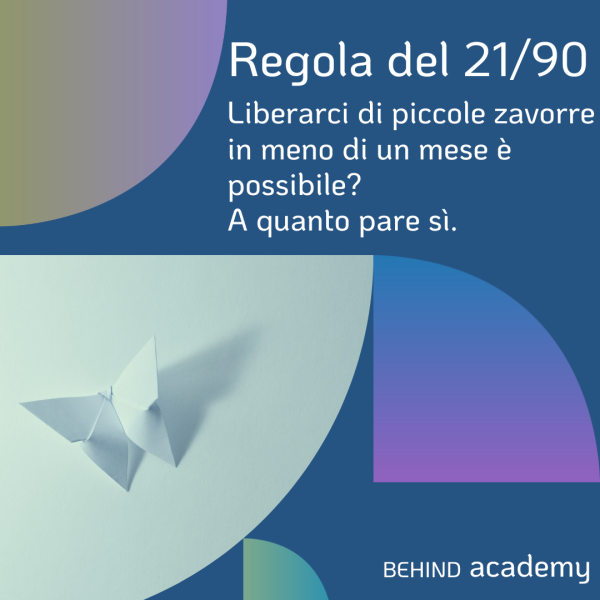Quando la moda ci insegna ad indossare il linguaggio
Il detto è noto: “chi non mostra non vende”, e in questa settimana milanese dove la moda penetra in ogni strada della città che non riposa mai, gli addetti ai lavori – e non solo – prendono alla lettera queste parole. L’abito da solo sembra proprio non bastare più, e anche se la qualità si riconosce a colpo d’occhio, c’è bisogno di tutta una serie di accortezze e dettagli, che trasformano una semplice sfilata in una vera e propria messa in scena, dove il gusto, la creatività e l’ingegno hanno il chiaro intento di veicolare un messaggio. Insomma, la moda parla e comunica e quando decide di farlo non lascia nulla al caso.
E se queste strategie non fossero solo ad appannaggio dei guru del fashion? Se provassimo anche noi comuni mortali a rubare i pregiati dettami di divi e divine?
Fingere quindi? Tutt’altro. In realtà la finzione si annulla difronte al provare qualcosa, al bisogno di voler essere qualcuno piuttosto che un altro. Quel feeling trasforma la finzione in gioco, e il gioco ci attribuisce una leggerezza in grado di farci volare altissimi. Ma, purtroppo, noi uomini e donne della vecchia Europa dobbiamo ancora fare nostre le regole di questa incompresa sorella, e tendiamo ancora a confondere la serietà con l’essere seriosi. Ma la moda sembra non aver mai confuso i termini, consapevole del fatto che nel momento in cui si prenderà troppo sul serio smetterà di funzionare. Tuttavia noi umani, a differenze dei divini, confondiamo e pratichiamo la serietà nel modo sbagliato.
Il dramma, nel senso inglese del termine, ovvero drama, può fare miracoli: è un colore, un suono, una vibrazione che non dovrebbe mai mancare nelle nostre vite. È la capacità di tradurre noi stessi in modo avvincente e luminoso, che non ha niente a che vedere con il significato negativo che spesso tendiamo ad attribuirgli. Per usare le parole di Dale Carnegie, nel suo ancora attualissimo Come trattare gli altri e farseli amici, “questo è il tempo della drammatizzazione. La verità da sola non basta. Deve essere resa vivida, interessante, drammatica, si deve usare uno stile spettacolare. Lo fa il cinema, lo fa la televisione, e lo dobbiamo fare anche noi se vogliamo ottenere attenzione.” E se questo era vero nel 1936, anno in cui il testo di Carnegie fu pubblicato, oggi lo è doppiamente, oggi urge dare luce a parole ed emozioni, per mostrarli al meglio. Eppure sembra così complicato. Perché?
Circondati da tante passioni liquide abbiamo dimenticato come confessare a noi stessi ciò che proviamo, a definire i nostri sentimenti e comportamenti se non come conseguenza dei sentimenti e comportamenti altrui. La causa di come ci sentiamo deriva quasi sempre da qualcos’altro da noi. La loro rabbia diventa la nostra rabbia, il loro feeling diventa il nostro feeling, senza alcun pensiero, senza alcun ragionamento. Perché, diciamocelo, oggi ragionare stanca. Raramente ci prendiamo del tempo per chiederci cosa ha suscitato in noi una determinata reazione, ma siamo esperti nel diagnosticare gli altri, nel valutarli, nel pre-giudicarli, e in questo non c’è drama, ma solo dramma. È un atto tragico, che schiva ogni possibilità di connessione. E l’arte, come la moda (perché la moda è arte, per quanto questo faccia inorridire i radical chic) sembra conoscere da sempre questa regola. La moda osserva, imita, elabora, trasforma, crea. Un’operazione di enorme portata cognitiva ed emotiva, che se usata con metodo ci consentirebbe di allargare le nostre possibilità di pensare e sentire, facendoci “contaminare” da quanto proviene dall’esterno, senza chiuderci nelle nostre convinzioni. Possiamo e dobbiamo diventare abili sarti, imparare a vestire il linguaggio. Renderlo calzante e incalzante. Insomma, dobbiamo trovare il nostro stile, la nostra cifra, il nostro ritmo, perché tutti possiamo avere delle debolezze, ma spero che in pochi aspirino a restare persone ordinarie. Proviamo di continuo felicità, rabbia, disagio, benessere, appagamento, sofferenza, ma siamo in grado di esprimerli chiaramente a parole, per permettere a chi ci è accanto di capire quello che accade dietro il paravento della nostra quotidianità? Sappiamo dare un nome a ciò che sentiamo? Perché di questo si tratta: decodificare le emozioni che sentiamo, attraverso l’uso di un codice chiaro e specifico. La moda lo fa da sempre, ha trovato i suoi codici. Criticabili? Eccessivi? Esagerati? Può essere, ma sono codici vivi, che anche nell’eccesso conservano la propria dignità d’espressione, che in ogni sfumatura non perdono mai di vista la propria identità. La moda, proprio come la comunicazione efficace, non si adatta, ma si integra ed è questo a renderla eterna e tanto desiderabile.
E quando noi umani impareremo ad essere un po’ divini? Nel momento in cui smetteremo di guardare gli altri come qualcosa di criticabile ma di assimilabile, quando inizieremo a farci domande e a non fermarci alle sole risposte, così da trasformare continuamente il nostro linguaggio, per diventare degli stagionali della comunicazione. Perché anche le parole amano il cambiamento. Partiamo smettendo di preoccuparci di ciò che pensano gli altri, e iniziamo a dare forma alle nostre opinioni, a valorizzare noi stessi, senza perdere l’abitudine di metterci in discussione. L’importante è restare credibili – tenendo a bada i confini dell’identità e della dignità – e allora state pur certi che nessuno farà quel gesto come lo farete voi, nessuno avrà il vostro swing, il vostro ritmo, nessuno si approprierà del vostro linguaggio.
La moda sa che il linguaggio è diversità e che la diversità è unicità, ma la moda sa anche un’altra cosa, che infondo un po’ tutti abbiamo quel “disperato bisogno di CHANEL”.